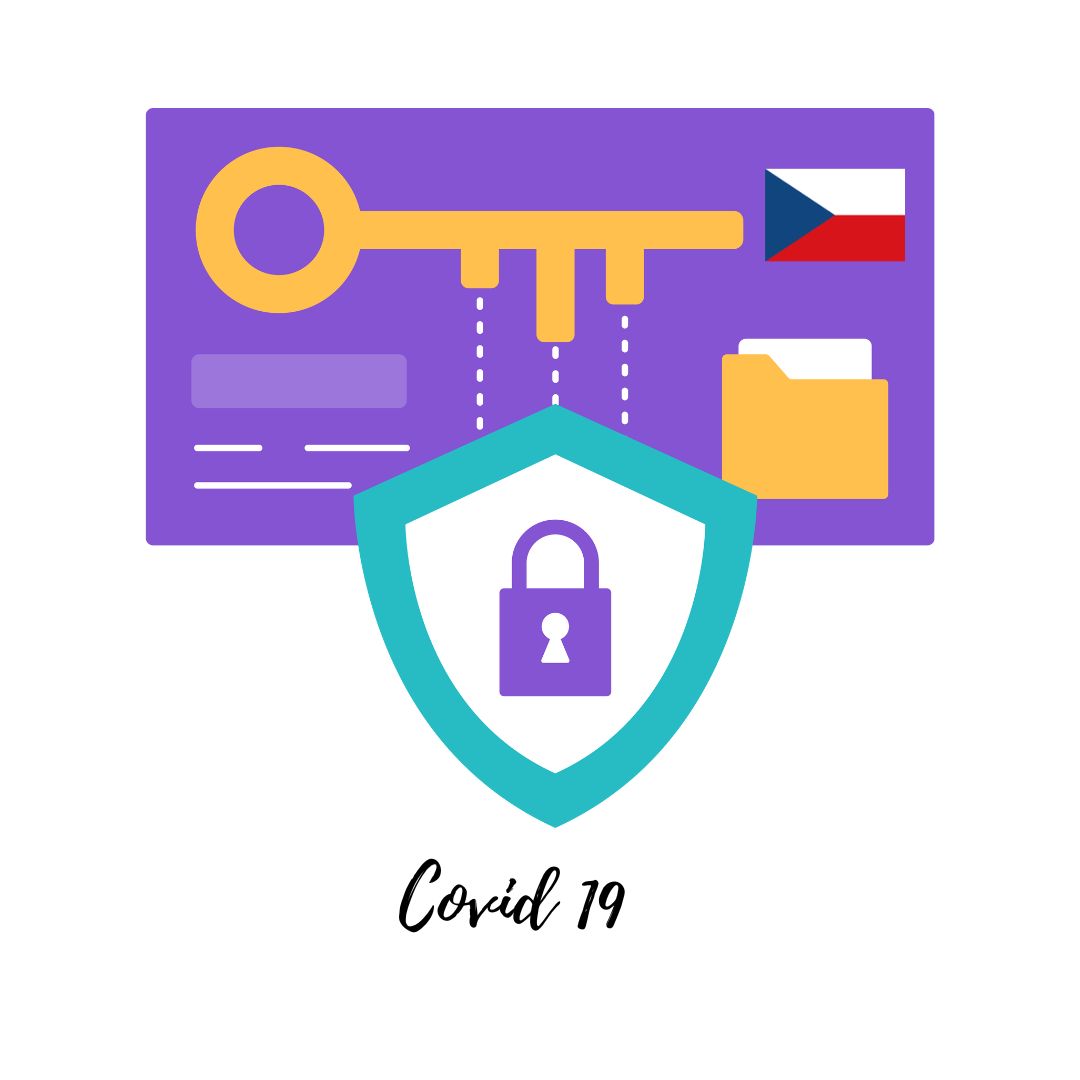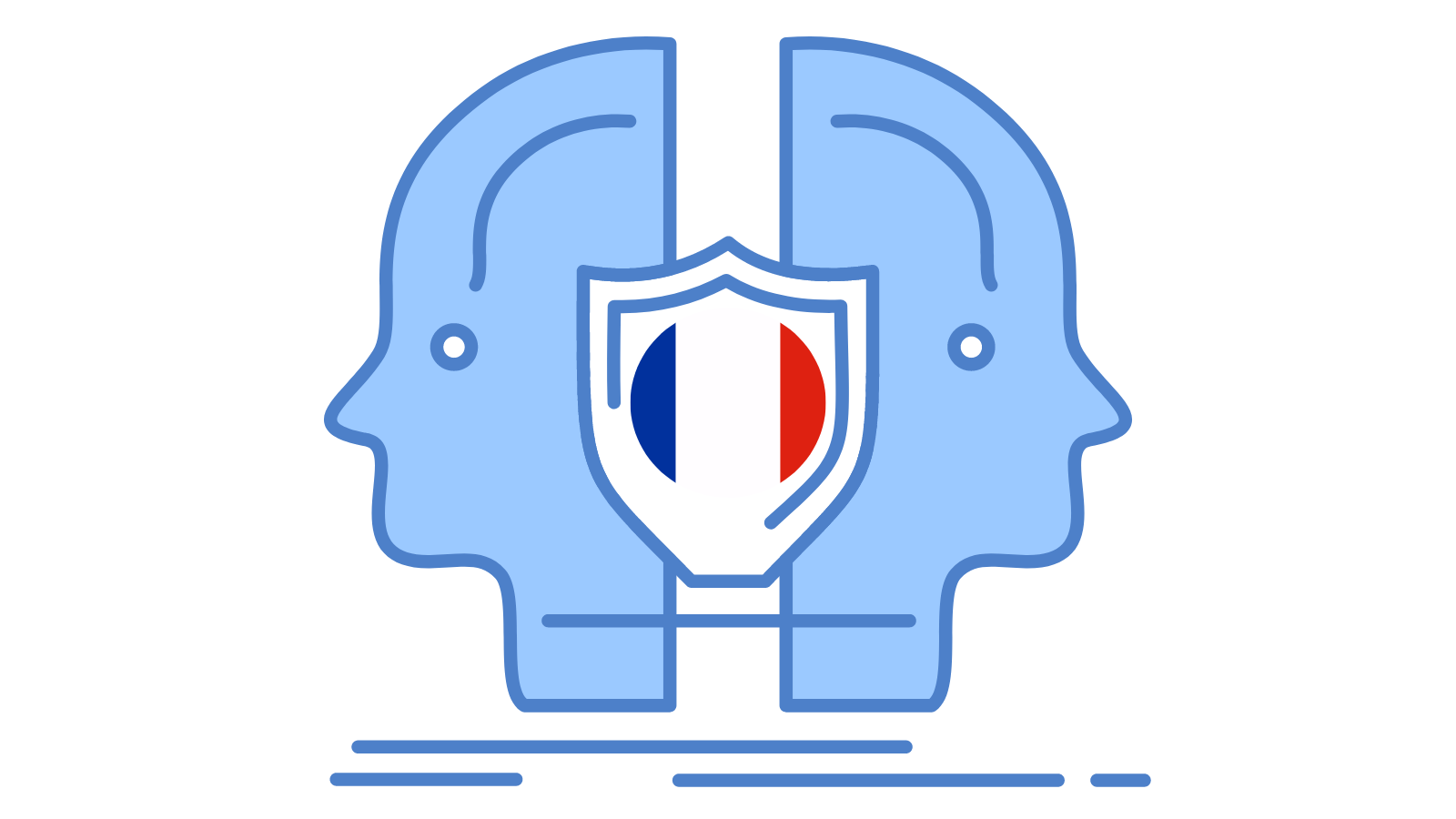Il Garante della Repubblica Ceca sanziona il Ministero dell’InternoTrattamento diffuso di dati sul Covid-19 senza idonea base giuridica L’Autorità Garante privacy della Repubblica ceca ha inflitto una sanzione da 975.000 corone al Ministero dell’Interno per il trattamento diffuso dei dati delle persone alle quali era stato ordinato l’isolamento a causa del COVID-19.Secondo l’Ufficio, il caso …