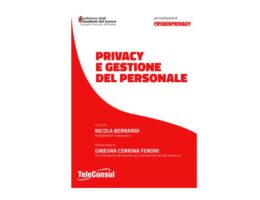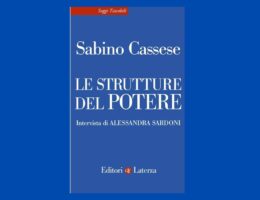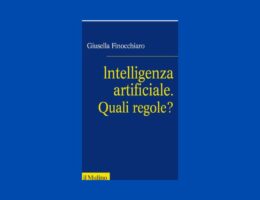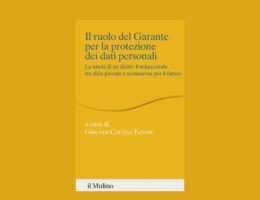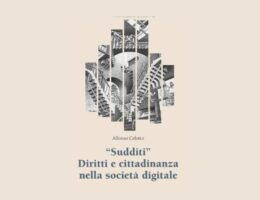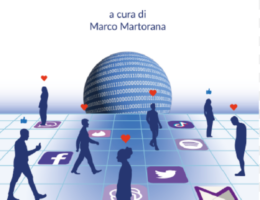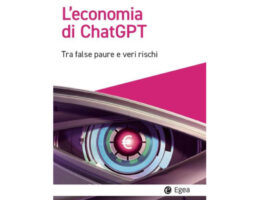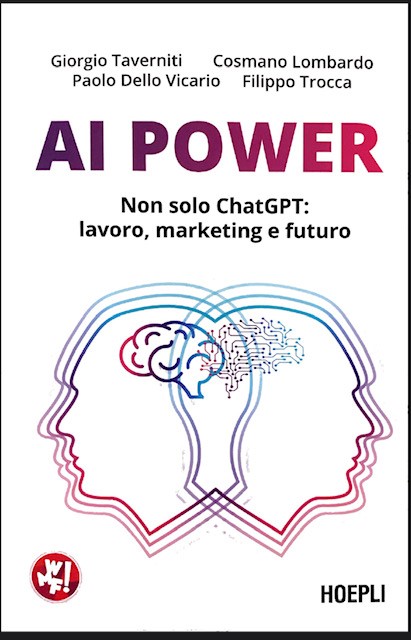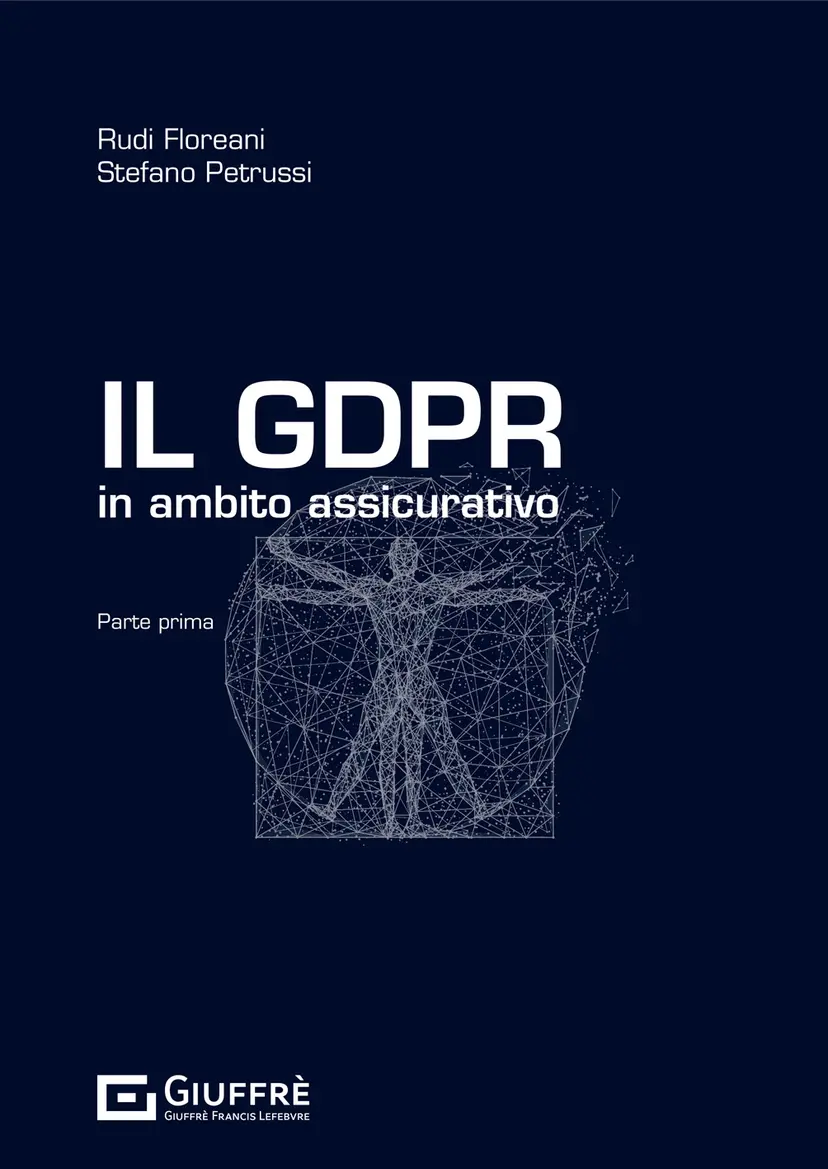Guida operativa di Alberto Paoletti e Gianpaolo Luzzi (BTT Editori) La conoscenza delle norme, degli spazi operativi, delle tecniche e, soprattutto, dei limiti entro i quali può essere svolta una corretta attività investigativa privata, costituiscono gli obiettivi che si sono posti gli autori di questo volume per accompagnare i professionisti dell’attività investigativa ma anche avvocati, …